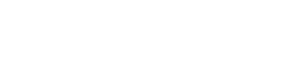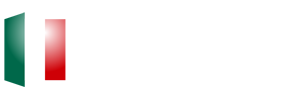L’86% del gettito resta a Roma ma Regioni e Comuni pagano il conto
Nel 2023 i #contribuenti italiani hanno versato 613 miliardi di euro di #tasse, una cifra enorme che fotografa il peso della #pressionefiscale sul Paese. Ma la distribuzione di questo gettito racconta una realtà squilibrata: l’86% di quanto raccolto, pari a 529,4 miliardi, finisce direttamente nelle casse dello #Stato centrale, mentre a #Regioni e #Comuni resta soltanto il 14%. Una percentuale minima, soprattutto se confrontata con il volume delle spese che gli enti locali sono chiamati a sostenere. La spesa pubblica complessiva, escludendo pensioni e interessi sul debito, ammonta infatti a 644 miliardi e di questi ben il 44% è gestito da Regioni e Comuni. In altre parole, lo Stato incassa la quasi totalità delle tasse, ma sono gli enti territoriali a dover garantire molti dei servizi quotidiani più vicini ai cittadini: dalla sanità al trasporto pubblico, dal welfare locale all’edilizia abitativa, fino a settori come la manutenzione delle scuole o le politiche sociali.
Il problema, come sottolinea la CGIA di Mestre, è che negli ultimi trent’anni molte competenze sono state decentrate ma senza che ci sia stato un adeguato trasferimento di risorse autonome. Le Regioni e i Comuni dipendono ancora in gran parte dai trasferimenti provenienti da Roma e la loro autonomia finanziaria è fortemente limitata. Così, a fronte di entrate che rimangono nelle mani dello Stato centrale, gli enti locali devono ricorrere a ticket sanitari, addizionali Irpef o tributi come Imu e bollo auto per riuscire a finanziare i servizi che i cittadini si aspettano. In sostanza, i cittadini pagano due volte: una volta attraverso la fiscalità generale e un’altra attraverso le imposte e le tariffe locali.
Le principali voci che alimentano le casse dello Stato restano Irpef, con oltre 208 miliardi, Iva, che ne porta 140, e Ires, con quasi 50 miliardi. Alle Regioni vanno soprattutto Irap, addizionale Irpef e bollo auto, mentre i Comuni si reggono su Imu e addizionale comunale Irpef. Una ripartizione che evidenzia la sproporzione e che spiega perché Regioni come Veneto e Lombardia, già nel 2017, abbiano chiesto con forza maggiore autonomia dopo i referendum consultivi. Non è un caso che il tema del cosiddetto residuo fiscale sia diventato centrale: la Banca d’Italia ha calcolato che nel 2019 ogni cittadino veneto ha contribuito al bilancio pubblico con un saldo negativo di 2.680 euro, ossia ha dato allo Stato molto più di quanto abbia ricevuto in termini di spesa pubblica.
Secondo la CGIA, il centralismo fiscale continua a penalizzare le aree più produttive del Paese, costrette a versare risorse ingenti senza vederne un ritorno proporzionato. Allo stesso tempo, nel Mezzogiorno i trasferimenti statali restano superiori alle entrate generate localmente, una dinamica che alimenta tensioni e mantiene acceso il dibattito politico sull’autonomia differenziata. Il nodo è sempre lo stesso: come rendere più equilibrato il rapporto tra chi produce ricchezza e chi beneficia della spesa pubblica, evitando che intere regioni vivano con un senso di penalizzazione fiscale. È un tema che intreccia economia e politica e che nei prossimi anni sarà sempre più decisivo per definire gli equilibri tra centro e periferia, tra Stato e autonomie locali, tra la promessa di una maggiore efficienza e la necessità di garantire coesione nazionale.